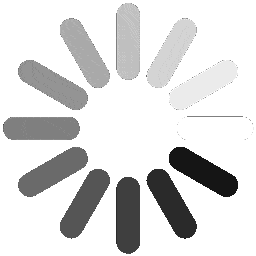Scopri il contenuto di questa pagina in breve
L’era della mitigazione è finita: architetti e progettisti devono prepararsi a un mondo instabile e in continuo cambiamento. È nata l’età dell’adattamento. Ecco cosa significa tutto ciò per l’edilizia del prossimo futuro.
Architettura adattiva: la risposta a un mondo instabile
Per anni, la parola d’ordine dell’edilizia sostenibile è stata “mitigazione”. Significava progettare edifici a basso consumo, materiali a ridotto impatto, tecnologie per limitare le emissioni. Ma oggi, mentre il cambiamento climatico corre più veloce delle soluzioni, un’idea prende piede: non basta più ridurre i danni, dobbiamo imparare a convivere con essi. Inizia così l’era dell’adattamento e dell’architettura adattiva, come evoluzione della bioarchitettura.
A lanciare la provocazione è Carlo Ratti, architetto e docente al MIT di Boston, curatore della Biennale Architettura 2025. La sua visione è netta: entrare in quella che chiama “età dell’adattamento”. In pratica, accettare che certi scenari estremi sono ormai inevitabili – innalzamento dei mari, eventi climatici imprevedibili, scarsità idrica – e ripensare l’architettura come un organismo vivo e reattivo.
L’adattamento non è rassegnazione, ma evoluzione. Significa progettare edifici capaci di cambiare pelle, di reagire al caldo, di immagazzinare l’acqua, di interagire con il territorio. In questa visione, la casa del futuro non è un bunker ecologico, ma una cellula intelligente che coopera con l’ambiente.
Scopri l’era dell’adattamento: così cambia davvero l’edilizia
L’età dell’adattamento è un salto concettuale che va oltre la sostenibilità di facciata. Richiede un cambio di paradigma: non progettare più “contro” gli eventi estremi, ma “con” essi, sfruttando le potenzialità di ogni contesto.
Alla Biennale, questa idea prende forma attraverso materiali ibridi (come la terra cruda unita alla stampa 3D), soluzioni bioispirate e design collaborativi. Ma soprattutto, emerge un concetto: l’architettura deve attingere a ogni forma di intelligenza disponibile, sia essa naturale, artificiale o collettiva. Non è più solo questione di estetica o funzione: è questione di sopravvivenza.
Adattarsi significa coinvolgere anche scienze, arte, artigianato, filosofia, persino gastronomia. I progetti esposti vedono lavorare insieme architetti, biologi, climatologi, matematici, agricoltori e designer. È un’architettura multidisciplinare, che si nutre di conoscenza trasversale per affrontare un mondo complesso e instabile.
Strategie e soluzioni per una nuova edilizia resiliente
Tradurre l’adattamento climatico in edilizia concreta non è solo questione di teoria. Significa cambiare priorità nei cantieri, nelle ristrutturazioni, nelle urbanizzazioni. Ecco alcuni esempi già emersi:
- Uso di materiali porosi e naturali, in grado di regolare l’umidità e abbattere l’effetto isola di calore (es. terra cruda, canapa, sughero).
- Strutture mobili o trasformabili, che si adattano a cicli stagionali estremi o a territori instabili.
- Sistemi passivi intelligenti, come tetti ventilati, pareti verdi e orientamento solare dinamico.
- Integrazione di sensori e AI per monitorare in tempo reale consumi, stress strutturali, microclima.
- Progettazione partecipata e collettiva, per edifici più adatti alla comunità e ai bisogni reali.
In questa visione, l’edilizia non è più solo costruzione, ma progettazione evolutiva di habitat complessi. Serve un pensiero nuovo, che consideri ogni intervento – dal piccolo restauro alla smart city – come un tassello di adattamento collettivo.
Il futuro è incerto, ma l’architettura può essere una risposta. Non più un baluardo statico, ma un alleato attivo nell’affrontare il cambiamento. Perché la vera sostenibilità oggi non è resistere, ma sapersi trasformare.