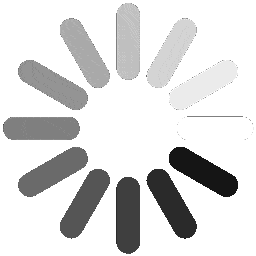Scopri il contenuto di questa pagina in breve
Vanno a caccia di luoghi abbandonati – che in Italia non mancano – per provare emozioni forti. Sono sempre di più gli urbexer nel Bel Paese, ma la cronaca ci mostra che spesso non sanno i pericoli che corrono!
Urbex cos’è e chi lo pratica
In Italia gli edifici abbandonati sono milioni di metri quadri e migliaia di siti: non solo “scorci instagrammabili”, ma vere capsule della memoria. Le persone che le visitano praticano l’urbex, acronimo di urban exploration, ovvero l’esplorazione urbana alla ricerca di posti dimenticati e fuori dal tempo.
Quanti sono e dove sono gli edifici abbandonati in Italia
La mappa dell’abbandono in Italia è vasta e capillare. Il motivo? La mancanza di fondi, o la mancata convenienza economica: gli enti pubblici, ma anche società e privati, spesso preferiscono non sostenere i costi per consolidare il solaio, o altri elementi strutturali lasciando andare in malora caserme, ospedali, colonie marine estive, ma anche ville storiche, fabbriche e chiese.
I dati più recenti fotografano un fenomeno tutt’altro che marginale:
- oltre un milione e mezzo di edifici in rovina, pari a circa il 6% dell’intero patrimonio immobiliare nazionale (stime Istat e Cescat Assoedilizia);
- circa 5.300 “paesi fantasma” secondo Legambiente: quasi la metà in avanzato degrado urbano, gli altri già completamente spopolati;
- più di 50.000 tra ex palazzi storici ed ex castelli nobiliari in condizioni di forte ammaloramento;
- circa 20.000 edifici ecclesiastici dismessi (chiese, abbazie, conventi);
- almeno 3.300 ex caserme: 1.500 risultano ufficialmente dismesse, con oltre un terzo localizzato in Friuli-Venezia Giulia;
- oltre 400 teatri chiusi (molti vincolati): maglia nera a Sicilia (59) e Lombardia (57);
- colonie abbandonate soprattutto lungo la costa nord-adriatica: solo a Cesenatico se ne contano 73;
- a Milano, circa l’11% dei 12 milioni di mq di uffici risulta inutilizzato secondo lo Urban Land Institute.
In molte aree sovra-urbanizzate si arriva a una casa vuota ogni dieci: se si accostassero tutti questi immobili in fila, coprirebbero l’intera superficie della Valle d’Aosta. È su questo corpo enorme (e fragile) che s’innesca l’attenzione crescente degli esploratori urbani.
Quali sono le regole del perfetto urbexer?
L’urbex è una pratica di frontiera, affascinante ma mai “libera tutti”: si muove sul crinale tra curiosità culturale e rischi concreti, materiali e… legali. Tra i gruppi di appassionati circola un codice etico minimo, semplice ma imprescindibile:
- si porta via solo il ricordo, si lascia solo l’impronta: niente “souvenir”, nulla si sposta, nulla si prende;
- si entra soltanto da varchi già aperti: niente forzature, per non sconfinare nella violazione di domicilio;
- tempi brevi: la sosta non dovrebbe superare un paio d’ore, per non configurare occupazione;
- sicurezza prima di tutto: pavimenti da tastare e coperture da osservare, attenzione a tegole, sfondellamenti del solaio e crolli locali;
- dotazione minima: pantaloni lunghi, guanti, scarpe a suola rigida o antinfortunistiche; utile una torcia;
- mai da soli: luoghi isolati possono ospitare senzatetto o risultare insidiosi; in caso d’incidente serve aiuto immediato.
Perché è pericoloso e cosa insegnano i fatti di cronaca
La cronaca lo ha ricordato con durezza. All’ex Scuola Sommergibilisti di Venezia, struttura inutilizzata da decenni, una diciassettenne è precipitata per circa 6 metri dopo il cedimento di una porzione di tetto al crepuscolo. L’amico, illeso, ha lanciato l’allarme. Poco mesi fa, in una villa abbandonata, alcuni urbexer hanno fatto una macabra scoperta: due corpi mummificati di una coppia di coniugi.
Questi episodi non “demonizzano” la curiosità, ma ne mostrano i limiti: se intercetti un immobile pericolante in area accessibile, la via corretta non è entrarci: è segnalarlo al Comune o alla Polizia locale. Il fascino dell’abbandono è potente, ma la sicurezza vale più di qualsiasi “scatto perfetto”.