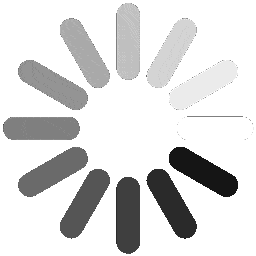Scopri il contenuto di questa pagina in breve
Dall’efficienza energetica alla rigenerazione: l’edilizia sostenibile cambia pelle. Niente più solo “carbon neutral”, ora gli edifici devono generare benessere, energia e valore sociale. Il futuro? È già iniziato in 130 progetti nel mondo.
Il green building è superato: arriva l’edilizia rigenerativa
La transizione ecologica del settore edilizio sta vivendo una nuova svolta. Dopo anni di focus sull’efficienza energetica e la neutralità climatica, si punta sull’edilizia rigenerativa.
Gli edifici sostenibili, capaci di impattare meno, non bastano più. Servono costruzioni in grado di generare valore ambientale, sociale ed economico. A lanciare la provocazione è Carlo Battisti, presidente di Living Future Europe: «Il green building è morto, lunga vita al green building». L’obiettivo non è più limitarsi a “fare meno danni”, ma progettare spazi rigenerativi, capaci di restituire risorse, attivare benessere e incentivare la biodiversità urbana.
Un cambio di paradigma che si riflette in nuovi standard internazionali di certificazione, primo fra tutti il protocollo Living Building Challenge: il più avanzato e rigoroso al mondo. Questa certificazione – applicabile a edifici nuovi, ristrutturazioni e interni – richiede che il progetto sia olistico e risponda a 7 categorie di prestazioni ambientali e sociali:
- luogo;
- acqua;
- energia;
- salute e felicità;
- materiali;
- equità sociale;
- bellezza.
Non solo: la certificazione viene rilasciata solo dopo 12 mesi di monitoraggio reale post-occupazione, con validazione di un revisore indipendente. Niente dichiarazioni sulla carta, contano solo i risultati concreti.
Quali edifici sono già un modello di sostenibilità rigenerativa?
Oggi parlare di “efficienza energetica” non è più sufficiente: la sfida è trasformare l’edificio da entità passiva a soggetto attivo nel migliorare il mondo. Non solo ridurre l’impatto, ma rigenerare ambiente e società.
Nel mondo sono già oltre 130 gli edifici certificati Living Building Challenge, e altri 200 sono in fase di realizzazione. Tra gli esempi più noti:
- Bullitt Center a Seattle: il primo edificio commerciale LBC, produce il 60% di energia in più di quella che consuma e utilizza esclusivamente acqua piovana, grazie a un sistema di filtraggio avanzato.
- PAE Living Building a Portland (2024): 5.300 m² su sei piani, energia prodotta pari al 108% del fabbisogno, 98% dei materiali da costruzione riutilizzati, design biofilico e orto in terrazza.
- Sede Google a Londra e hub logistico Prologis a Eindhoven, oltre a progetti residenziali nei Pirenei, dimostrano che la sostenibilità rigenerativa è scalabile anche per aziende e operatori privati.
Nonostante i costi iniziali superiori, i ritorni ambientali ed economici dell’edilizia rigenerativa sono già evidenti: secondo stime, il Bullitt Center genererà benefici per oltre 18 milioni di dollari nel suo ciclo di vita. Oggi quei costi – grazie all’innovazione e alle economie di scala – sono destinati a ridursi ulteriormente.
Perché l’Italia è in ritardo nella sfida per l’edilizia rigenerativa?
Nel nostro Paese il modello rigenerativo stenta a decollare. Le tecnologie sono disponibili, gli esempi internazionali abbondano, ma secondo Battisti «serve una vera rivoluzione culturale nel settore delle costruzioni». In Italia ci sono le competenze e le risorse, ma il settore è ancora legato a logiche conservative e incentivi poco lungimiranti.
La vera sfida? Non è tecnica, ma psicologica. Chi sceglie oggi di progettare con i criteri dell’edilizia rigenerativa investe sul lungo termine, sulla salute delle persone, sulla reputazione aziendale e sulla qualità urbana. Eppure, la domanda è semplice: che senso ha costruire oggi un edificio che domani sarà già obsoleto?
L’auspicio è che il nostro Paese cominci a investire con decisione in questa nuova visione, sfruttando normative, fondi e know-how per favorire la nascita di edifici che facciano bene a chi li abita e al Pianeta intero.